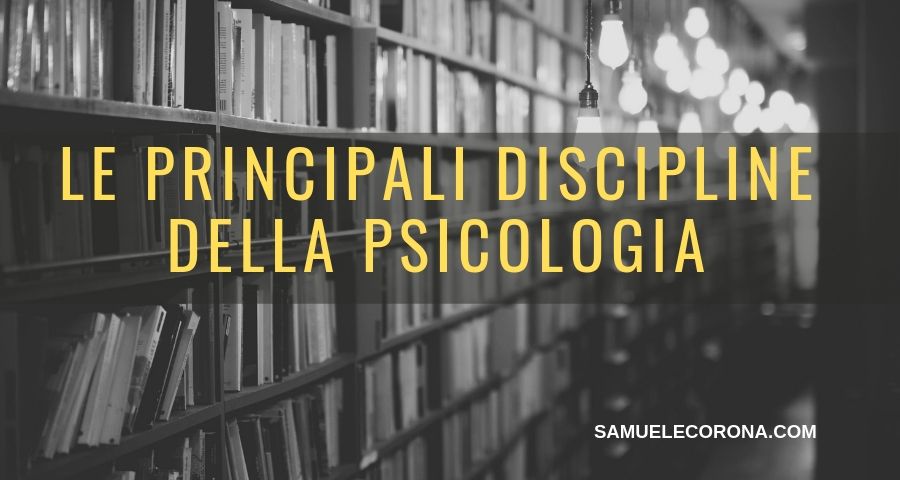Tra tutte le scienze, la psicologia è forse la più misteriosa per i non addetti ai lavori, e quella che maggiormente si presta agli equivoci. Anche se ritroviamo il suo linguaggio e i concetti nella cultura quotidiana, i più hanno un’idea nebulosa degli argomenti che tratta e di ciò che fanno gli psicologi.
“Psicologia” deriva dal greco antico psiche, che significa “anima” o “mente”, e logia, “studio” o “descrizione”, il che sembra riassumere la sua vasta portata, ma oggi la parola descrive più precisamente “la scienza della mente e del comportamento”.
Poiché il comportamento umano è così vario, anche il numero di discipline della psicologia è in costante crescita ed evoluzione. Il post descrive alcune tra le più importanti discipline psicologiche.
Psicologia culturale
La psicologia culturale nasce dalla premessa che l’esperienza umana non può prescindere dalla natura sociale e che la realtà, all’interno della quale gli individui agiscono, contribuisce alla definizione dei saperi.
Inevitabile è uno scambio reciproco tra elementi diversi e concorrenti che ne escono modificati. Nell’attuazione di questo processo accade che il mondo simbolico si evolva e si arricchisca innestando aspetti nuovi su quelli legati alla tradizione senza, tuttavia, distruggerli.
Ne deriva che alla definizione della personalità di un individuo concorrano saperi e pratiche la cui collocazione è nell’ambiente l’ambiente culturale di provenienza.
Per questo motivo Jerome Bruner propone una scienza mentale tale basata su percorsi che si evolvono all’interno della comunità di appartenenza, contribuendo buendo alla formazione sia della personalità degli individui sia della cultura.
La vitalità di entrambi i fattori, individui e cultura, si esprime attraverso la capacità di risolvere i conflitti, comprendere le differenze, rinegoziare i significati.
Un ruolo significativo e rappresentativo viene assolto dal linguaggio proprio per l’importanza che possiedono le funzioni comunicative e formali nella reiterazione culturale.
Psicologia del lavoro
Campo della psicologia applicata, avente come oggetto di ricerca le attività lavorative dell’uomo, con riferimento all’ambiente in cui vengono messe in atto e alle relazioni interindividuali o umane implicate.
La finalità intrinseca di quest’ambito della psicologia dovrebbe essere l’ottimizzazione della prestazione del lavoratore e al contempo tempo della sua gratificazione; invece, a seconda della concezione abbracciata, si pone in una prospettiva produttivistica, fondata sull’organizzazione del lavoro, ovvero in una prospettiva particolarmente attenta all’adattamento e all’evoluzione del soggetto e quindi al suo atteggiamento verso la propria attività lavorativa.
Nel 1905, il primo obiettivo che la psicologia del lavoro si propone è lo studio e la prevenzione della fatica: in Germania, Emil Kraepelin usa per primo il metodo sperimentale nello studio dell’attività lavorativa e nel tentativo di misurarne lo sforzo.
La nascita della psicologia del lavoro, però, si deve a Hugo Munsterberg (1913), la cui attività è finalizzata alla creazione di una nuova scienza che fa da ponte tra la psicologia di laboratorio e l’economia politica, e a Lahy che, al contempo in Francia, conduce importanti ricerche sulle condizioni di lavoro di talune categorie professionali, sionali, adottando un metodo antitaylorista.
Durante la Prima Guerra Mondiale, l’attività preponderante degli psicologi del lavoro è rivolta alla selezione del personale militare, mentre alla fine degli anni Trenta è occupata dai problemi connessi alla selezione professionale, in cui si avvale dei metodi della psicologia differenziale, essenzialmente quello dei test.
Dal dopoguerra a oggi, l’ampliamento e la diversificazione del raggio di azione della psicologia del lavoro possono essere sintetizzati da quattro diversi interventi (selezione, formazione, orientamento professionale, ergonomia) che rappresentano la via di accesso della psicologia all’ambiente lavorativo, costituiscono una serie di conoscenze tecniche e pratiche di cui attualmente si servono diverse altre discipline e rispondono alle problematiche concrete inoltrate dalle organizzazioni.
Psicologia dell’arte
Ambito della psicologia che, in collaborazione con l’estetica e la critica d’arte, utilizza teorie e metodi psicologici per l’analisi dei fenomeni e delle produzioni artistiche. Il campo di indagine si riferisce alle arti figurative, ma anche alla musica e alla letteratura.
Essa investe quelle aree di studio che riguardano i meccanismi percettivi, visivi e motori; i processi cognitivi come l’immaginazione e la memoria; la personalità nelle varie componenti motivazionali ed emotive; la produzione come capacità rappresentativa, grafica e simbolica.
La psicologia scientifica dell’arte nasce nel XIX sec. per opera di G.Th. Fechner. Egli distingueva l’estetica filosofica, che muove dai principi per arrivare alle produzioni artistiche, dall’estetica empirica, che muove dal particolare per cercare principi generali verificabili sperimentalmente. Oggi, però, molte delle sue tesi sono state superate in quanto il suo lavoro risente dei limiti di un’impostazione esclusivamente quantitativa.
La teoria psicoanalitica, invece, ha promosso nuovi e importanti portanti sviluppi nel settore degli studi sull’arte centrati sul nesso supposto tra impulsi creativi e motivazioni profonde.
Freud definisce l’arte come un appagamento sostitutivo di un rapporto interrotto con la realtà, e l’artista come colui che, in disaccordo con la vita, è capace di realizzare, attraverso la fantasia e le proprie attitudini, i suoi desideri di amore e di gloria e di trovare la strada per ritornare alla realtà.
C.G. Jung si inserisce in modo significativo nel dibattito sulle relazioni tra psicologia e arte, ed evidenzia i rischi della metodologia freudiana che si allontana insensibilmente dal soggetto, facendo di ogni artista un caso clinico e di ogni opera d’arte una malattia. Per Jung l’opera d’arte è una produzione che va oltre l’individuo, poiché il suo significato non è rinvenibile nelle condizioni umane che l’hanno prodotta.
Psicologia dell’età evolutiva
Settore della psicologia che si occupa del progressivo sviluppo delle strutture psichiche dell’individuo e della loro organizzazione, dalla nascita sino alla soglia dell’età adulta.
Dal suo esordio nella seconda metà dell’Ottocento, in seguito a un articolo di Darwin (1877) relativo all’osservazione diretta di un bambino, sino a oggi, in cui è divenuta nuta la scienza dello sviluppo psichico, il campo di azione della psicologia dell’età evolutiva tiva si estende a diversi ambiti, dallo studio delle caratteristiche che assimilano e di quelle che distinguono il bambino dall’adulto, all’individuazione dei fattori ereditari rispetto a quelli ambientali responsabili dello sviluppo psichico, oltre all’analisi dell’evoluzione delle strutture psichiche più semplici in strutture psichiche più complesse.
1) La teoria dello sviluppo cognitivo
Occorre attendere sino agli anni Venti per assistere all’esplosione della psicologia genetica, il cui massimo contributo a livello europeo viene dato da J. Piaget, attraverso la pubblicazione de Il linguaggio e il pensiero del bambino (1923) e tramite la creazione, insieme ad alcuni collaboratori, del più attivo centro mondiale diale di ricerca sullo sviluppo psichico, divenuto in seguito il Centro Internazionale di epistemologia genetica.
Dopo aver elaborato una metodologia alquanto originale, Piaget mostra, oltre alla differenza qualitativa tra pensiero infantile e pensiero adulto, l’esistenza di diversi stadi dello sviluppo cognitivo, soltanto intuiti da ricerche precedenti alla sua, ma non evidenziati dall’uso di reattivi mentali, quali le scale di Binet.
Quella di Piaget, definita la teoria dello sviluppo cognitivo, è la teoria stadiale più autorevole della psicologia dello sviluppo. Attraverso stadi invarianti, egli definisce i cambiamenti che si verificano nel corso dell’acquisizione della conoscenza del mondo da parte dei bambini (epistemologia gia genetica).
Tali cambiamenti comportano modificazioni nella struttura del pensiero, che diviene sempre più organizzato costituendosi sulle strutture dello stadio precedente. La causa del passaggio attraverso gli stadi è individuata in differenti fattori, tra cui l’esperienza che attraverso due fondamentali processi, l’assimilazione e l’accomodamento, favorisce sce il progresso cognitivo.
I bambini sono perciò visti da Piaget come organismi attivi, in grado di autoregolarsi, i cui cambiamenti qualitativi e quantitativi sono indotti da fattori innati e ambientali: l’essenza dello sviluppo cognitivo è, quindi, rappresentata dal cambiamento mento di tipo strutturale.
2) La teoria psicoanalitica
I maggiori contributi alla psicologia dell’età evolutiva sono offerti ferti dalla psicoanalisi nelle sue molteplici varianti e, nello specifico, occorre ricordare la psicoanalisi infantile dal momento della sua nascita, attraverso l’opera di M. Klein e di A. Freud, della quale non si deve dimenticare il fondamentale testo L’Io e i meccanismi di difesa (1936), ed essenzialmente, per quanto riguarda l’interpretazione dello sviluppo affettivo fettivo e psicosessuale, l’enorme apporto fornito da S. Freud, che probabilmente fu il primo mo psicologo teorico a sottolineare l’importanza decisiva degli anni dell’infanzia per formare mare la struttura fondamentale del carattere.
La personalità di base, secondo Freud (1914), si costituisce nei primi 5 anni di vita attraverso i tentativi del bambino di far fronte a una sequenza invariante di conflitti, ciascuno dei quali coinvolge un diverso dominio: orale, anale, fallico e genitale (1905-1923). La modalità con cui il bambino appagale pulsioni di ogni stadio costituisce la base della personalità, ma, essendo lo sviluppo diretto da forti pulsioni sessuali, l’espressione di tali forze inconsce stimola lo sviluppo dell’Io e del Super-Io, per-Io, che operano anch’essi per gran parte in modo inconscio.
Freud propone, inoltre, al pari di Piaget, una teoria dello sviluppo basata sulle difficoltà, nel senso che ritiene che i disturbi o le fonti di conflitto del sistema inducano l’evoluzione del soggetto, la cui finalità è riportare lo stato di equilibrio nel sistema.
Egli ha quindi fornito differenti e duraturi contributi, empirici e teorici, alla psicologia dell’età evolutiva, stimolando ricerche attive tutt’oggi nelle aree della tipizzazione sessuale, dell’attaccamento, della relazione genitore-figlio, re-figlio, dell’aggressività e dell’identificazione.
3) La teoria vygotskijana-contestualista
Le radici del contestualismo sono molteplici, ma la forza storica di tale approccio nell’ambito della psicologia dell’età evolutiva è rappresentata sentata da Vygotskij (1926-1934). Notevole è l’incidenza che oggi tale teoria ha sulla psicologia dello sviluppo, essenzialmente nell’area dello sviluppo cognitivo.
La sua attenzione è fondamentalmente incentrata sull’integrazione delle acquisizioni quotidiane nello sviluppo, sulla sensibilità alla varietà nel percorso evolutivo, nonché sul contesto socioculturale culturale dell’evoluzione.
In merito a quest’ultimo punto, a differenza della stragrande maggioranza degli approcci, il contestualismo è focalizzato sul “bambino attivo in un contesto”, anziché sul singolo soggetto, di cui individua le funzioni mentali più alte in quelle sociali.
Esso ritiene che i minori usino gli strumenti culturali come sistemi simbolici, per far fronte ai problemi nei loro continui tentativi di raggiungere obiettivi nell’ambito di una realtà sociale e che gli ambienti sociali, le convinzioni culturali, i valori e le conoscenze influenzino le situazioni nelle quali i bambini sono incoraggiati a entrare.
Vygotskij propone, quindi, a differenza di Piaget, un tentativo coerente di esplicare le origini sociali del linguaggio e del pensiero (1934) ed evidenzia nel processo di transizione ne dal piano interindividuale a quello intraindividuale la legge cardine dell’evoluzione della conoscenza.
Rientra in tale area di studio la “zona di sviluppo prossimale”, distanza tra quanto il bambino può fare con o senza aiuto, in cui l’osservazione diretta del cambiamento mento verificatosi in ciascun attimo di un dato periodo consente di comprendere l’evoluzione del soggetto e la sua intelligenza, non definibile con quanto egli sa, bensì con ciò che acquisisce con l’ausilio altrui.
Peculiari sono le ricerche vygotskijane-costruttiviste sulla partecipazione guidata nelle zone di sviluppo prossimale, sul linguaggio egocentrico, sullo lo sviluppo dei concetti, nonché sugli studi cross-culturali.
4) La teoria etologica
Un’ importante sintesi tra i concetti psicoanalitici e gli assunti etologici ci viene compiuta da M. Ainsworth (1985) e da J. Bowlby (1969-1980).
È di quest’ultimo l’importantissima teoria dell’attaccamento, che, oltre ad ampliare, modifica la teoria freudiana, relativamente alla parziale irreversibilità delle esperienze precoci, relativizzando l’incidenza dei controlli motivazionali di tipo libidico e acuendo il significato evoluzionistico stico dell’attaccamento che unisce madre e bambino.
Sono emersi, inoltre, dati in favore dell’ipotesi che vi sia una predisposizione per cui il neonato e l’adulto interagiscono reciprocamente procamente (Lorenz, 1949), tanto da estendere le ricerche sugli effetti della separazione dalla madre, sulla madre stessa, quale base per l’esplorazione, e sul ruolo del padre.
Oltre all’attaccamento, le aree di ricerca individuate come rilevanti dalla psicologia etologica dell’età evolutiva sono quelle relative alla comunicazione non verbale, alle gerarchie di dominanza e alla risoluzione di problemi.
5) La teoria dello sviluppo percettivo
E.Gibson, massima esponente della teoria dello sviluppo percettivo, con Principles of perceptual learning and development (1968) elabora uno dei testi di psicologia dello sviluppo più influenti nella storia della psicologia dell’età evolutiva, occupandosi dello sviluppo e dell’apprendimento percettivo che nasce dall’incremento dell’efficienza percettiva, quale risultato dell’ esperienza.
Un’importanza cruciale riveste, in tale ambito, il contesto ecologico, in quanto il bambino impara a percepire le informazioni di cui si serve per adattarsi all’ambiente e, in talune situazioni, guidarne la raccolta è lo scopo.
Un recente saggio della Gibson (1988) evidenzia che si giunge alla conoscenza del mondo attraverso la percezione diretta dall’esplorazione attiva e che è tale conoscenza a guidare ciascuna nostra attività.
6) La teoria cognitiva
Spiega lo sviluppo cognitivo in termini di funzioni della crescita delle abilità di base, quali l’attenzione, la velocità di elaborazione delle informazioni e la memoria, prendendo come modello il sistema informatico.
Gli psicologi cognitivisti dello sviluppo dagli anni Ottanta si sono occupati della soluzione razionale di problemi, con l’obiettivo di studiare le modalità con cui il pensiero diviene sempre più organizzato e oggettivo, e hanno contribuito all’estendersi di un nuovo approccio, interattivo-cognitivista, secondo cui le precoci interazioni sociali influenzano in maniera determinante gran parte dello sviluppo cognitivo e linguistico successivo del bambino.
In base a tale approccio, si tende da una parte a spiegare la condotta sociale in termini cognitivi, social cognition, dall’altra a cogliere le possibili determinanti sociali dello sviluppo cognitivo.
Psicologia delle masse
- Editore: TEA
- Autore: Gustave Le Bon , Piero Melograni , Lisa Morpurgo
- Collana: Saggistica TEA
- Formato: Libro in brossura
- Anno: 2004
Referenti della prima ricerca compiuta in tale ambito sono le azioni distruttive delle folle rivoluzionarie francesi, che inducono G. Le Bon (1895) a sostenere che l’uniformità dei comportamenti dei singoli rilevabile nelle masse sia il risultato non tanto della vicinanza fisica o della concomitante presenza di più persone nel medesimo luogo, bensì di un cambiamento nei soggetti che induce al prevalere di istinti immediati e incontrollabili rispetto alla condotta razionale.
Secondo Le Bon, gli individui sembrano “cambiati” in massa e contraddistinti da condotte, atteggiamenti e idee nei quali singolarmente non si identificano.
Essi appaiono impotenti, privati della loro individualità da un'”anima collettiva”, capace di uniformarne, oltre che di plagiarne, il comportamento: nell’eccitazione generata dalla folla, la fusione degli individui in un sentimento comune cancella le differenze di personalità e di status, ottunde le facoltà psichiche, spingendo la massa a condotte talvolta eroiche, più spesso distruttive.
Le tesi di Le Bon vengono riprese e ampliate da G. Tarde (1890-1902), fondatore della psicologia della massa, al centro del cui interesse si evidenziano le folle artificiali e organizzate, di cui esercito, Chiesa e partiti politici sono prototipi.
Nel suo modello, le folle vengono individuate come capaci di creatività – elemento totalmente assente in Le Bon – in quanto, attraverso l’imitazione, le scoperte e i progressi compiuti dal capo, forza propulsiva del sistema, divengono la fonte dello sviluppo dell’umanità.
E infatti la “legge dell’imitazione”, meccanismo essenziale per la riproduzione e il cambiamento biamento della società e della sua cultura, che garantisce l’uniformità cognitiva e affettiva della massa e la sua sottomissione al capo: il reale fine del mondo è quindi la “ripetizione tizione generativa o imitativa”.
“Lo stato sociale, come lo stato ipnotico, non è che una forma del sogno, un sogno su comando e un sogno in azione. Non avere che idee suggerite rite e crederle spontanee: tale è l’illusione propria del sonnambulo, così come dell’uomo mo sociale.
Il rapporto da modello a copia, da padrone a suddito, da apostolo a neofita, prima di divenire reciproco o alternativo ha dovuto necessariamente cominciare con l’essere all’origine unilaterale e irreversibile”.
In linea con quanto affermato da Tarde, J. Ortega y Gasset individua nello sviluppo tecnico e produttivo l’origine degli agglomerati sociali e delle folle, caratterizzati dall’uniformità della vita.
Egli sostiene però che il processo di massificazione sia gratificante per gli individui, purché favorisca un alto soddisfacimento dei bisogni sociali, rispettando la naturale tendenza dei soggetti a un atteggiamento sociale passivo.
Al concetto di massa ha fatto largo riferimento anche che la psicologia del profondo, che ha cercato di individuare, nelle diverse esperienze dell’individuo nel corso dell’infanzia, le motivazioni della sua identificazione con la massa.
S. Freud (1921) è il primo a occuparsene e, anche se non condivide la tesi di Le Bon, secondo cui un soggetto cosciente sottostà a un istinto collettivo irrazionale nei momenti di aggregazione, ne accetta sostanzialmente la fenomenologia del comportamento mento collettivo.
Freud, pur definendo le masse che hanno un capo come l'”unione di singoli che hanno inserito nel loro Super-lo la medesima persona e si sono identificati fra loro nel proprio lo in base a questo elemento comune”, ritiene le caratteristiche che l’individuo manifesta nella folla come “peculiarmente sue” e la regressione a stadi più primitivi caratteristici della condizione di massa quale causa dell’indebolimento della rimozione.
“Le caratteristiche apparentemente nuove che egli (l’individuo) ora esibisce sono infatti manifestazioni dell’inconscio in cui tutto ciò che vi è di male nella mente umana è contenuto come predisposizione. Non ci è affatto difficile comprendere la sparizione della coscienza morale o del senso di responsabilità in queste circostanze”.
La massa è per Freud il momento nel quale il soggetto può liberare il suo inconscio ed esprimere tutta una serie di pulsioni sessuali irrisolte o inibite, attraverso la partecipazione zione emotiva, il comportamento irrazionale, la suggestione, l’identificazione con un modello di capo emergente: essa ha, in tal senso, una valenza positiva, in quanto sbocco della libido repressa e affrancamento delle pulsioni psichiche.
Freud, all’interno della psicologia della massa, formula il concetto di identificazione, quale sviluppo della teoria di Tarde sull’imitazione, inteso come differenziazione della psiche attraverso l’interiorizzazione di ideali sociali, autorità esterne e modelli, indicativo del provvisorio superamento peramento del narcisismo e dell’apertura nell’alterità.
La Scuola di Francoforte, con T.W. Adorno (1966), M. Horkheimer (1947) e H. Marcuse (1964), sostiene che le masse, pur mostrandosi socialmente e culturalmente evolute, sottostanno in verità a un alto grado di alienazione connessa alla persuasione occulta messa in atto dai detentori del potere economico e politico, attraverso i mezzi di comunicazione di massa.
E. Fromm (1955) ritiene sia indispensabile restituire al soggetto il senso del proprio valore, riconducendolo alla priorità dell’essere sulla condotta maggiormente livellante dell’avere.
Psicologia delle organizzazioni
Branca della psicologia che studia il comportamento di individui dui e gruppi all’interno delle organizzazioni lavorative. In questa accezione, le organizzazioni sono considerate artefatti sociali, caratterizzati dal coordinamento degli sforzi individuali, in vista del raggiungimento di obiettivi specifici e formalmente condivisi.
Di conseguenza, l’individuo è visto come un membro dell’organizzazione, che attraverso lo svolgimento dei propri compiti e dunque l’impiego di conoscenze, abilità e competenze contribuisce a un efficace funzionamento dell’organizzazione stessa, relazionandosi ed interagendo con altri individui e gruppi.
Di qui l’interesse di questa disciplina verso temi e campi di indagine quali ad esempio i processi di stabilità e cambiamento nel funzionamento delle organizzazioni, i meccanismi di influenza sociale, le reti di comunicazione, le relazioni intergruppi, le dinamiche nei gruppi di lavoro, il conflitto e la sua gestione, la cooperazione, il potere organizzativo, i processi di decisione sociale, di negoziazione, di progettazione organizzativa, la valutazione di efficacia ed efficienza dei processi organizzativi.
Psicologia industriale
La dicitura “psicologia industriale” è generalmente associata nella letteratura anglofona, specie di matrice statunitense, all’espressione “psicologia delle organizzazioni”, andando a creare un’unica disciplina, etichettata come “Industrial and Organizational Psychology”, che si occupa di diversi aspetti dell’agire organizzativo, dalla gestione della comunicazione organizzativa fino all’ottimizzazione dei processi produttivi, avendo come base scientifica e punto di riferimento i costrutti di natura psico-sociale e come focus di intervento privilegiato il supporto delle relazioni all’interno dei contesti organizzativi.
L’Industrial and Organizational Psychology si è sviluppata come disciplina autonoma con il successo industriale Europeo e Americano a cavallo tra Ottocento e Novecento, un successo che portava con sé anche nuove problematiche cui gli scienziati sociali erano chiamati a dar risposta, dall’inserimento lavorativo allo sviluppo delle performance di gruppo nei contesti occupazionali.
La dicitura “Industrial Psychology”, in senso stretto, ha una storia piuttosto curiosa, essendo apparsa per la prima volta in un articolo di Bryan del 1904 come errore tipografico, al posto di “individual psychology”; l’errore si trasformò in un lemma accettato dalla comunità scientifica che, come già detto, si lasciò affascinare dal nascente contesto industriale come ambito applicativo dei diversi modelli economico-sociali.
Nella prima parte del secolo scorso, fino agli anni ’50, le diciture “psicologia industriale”, “psicologia occupazionale” e “psicologia delle organizzazioni” sembrano tra loro interscambiali ed è solo a partire dalla seconda metà del secolo scorso che si fanno più sentite le distinzioni.
In modo particolare, per quanto concerne il contesto italiano, Marzi, nel 1951 propone di sostituire l’espressione “psicologia industriale” con “psicologia del lavoro”, temendo che l’etichetta “industriale” possa restringere il contesto applicativo della nascente figura dello psicologo del lavoro e della ricerca di natura organizzativa, interessati a qualsiasi ambito sociale-lavorativo, non solo a quello industriale in senso stretto.
Si noti che non viene suggerito semplicemente di sopprimere la dicitura “industriale” all’interno dell’espressione “psicologia industriale e organizzativa”, quanto piuttosto di sottolineare che la psicologia del lavoro è distinta dalla psicologia delle organizzazioni.
Con la proposta di Marzi si fa strada una distinzione che caratterizzerà le discipline lavoriste di taglio psicologico dell’Europa meridionale, distinguendole dal mondo anglosassone.
Nello specifico, in Italia e Francia “psicologia del lavoro” e “psicologia delle organizzazioni” fanno riferimento a due rami distinti del sapere psicologico applicato, dove il primo ha un’anima clinico-medico-ergonomica, tradizionalmente interessato alle tematiche dello stress e del benessere occupazionali, e il secondo un’anima ma aziendalistico-organizzativa, con un interesse nello studio dei rapporti tra l’individuo e l’incarico assegnatogli, l’individuo e gli altri attori organizzativi, l’individuo e l’organizzazione stessa.
Nei paesi di lingua anglossassone, dove lo sviluppo degli approcci clinicomedico-ergonomi medico-ergonomi ci è stato meno marcato, non esiste questa distinzione e si preferisce indistintamente parlare di “Industrial and Organizational Psychology” o di “Work and Organizational Psychology”.
Psicologia nell’arte
La psicologia nell’arte pone attenzione all’ analisi delle produzioni e delle personalità artistiche indagando su un fenomeno di per sé molto complesso come quello artistico.
Essa si muove tra aree di ricerca e di competenza diverse, avvalendosi di contributi provenienti da differenti ambiti teorici. Le sue origini vanno cercate in un clima positivistico, che ha favorito l’incontro tra arte e scienza attraverso il ricorso a metodi sperimentali, fino a trasformare l’atto artistico in una serie di leggi scientifiche.
Le principali interpretazioni sono quelle psicanalitica e gestaltista. La prima, che cerca una mediazione tra l’aspetto filosofico e quello scientifico, riconosce all’inconscio la capacità di scegliere il linguaggio attraverso il quale l’opera d’arte, riconducibile alla realtà delle strutture formali, potrà comunicare.
Gli autori della Gestalttheorie, o “psicologia della forma”, pongono la loro attenzione sui segni grafici, sui differenti modi del loro comporsi e sulla loro capacità espressiva, fino a stabilire delle vere e proprie leggi della percezione.
L’interpretazione gestaltista è, dunque, un riferimento importante per la psicologia dell’arte, poiché individua i processi mentali, cognitivi e affettivi presenti sia nella fase progettuale sia in quella del godimento dell’opera d’arte.
Psicologia sistemica
- Watzlawick, Paul (Autore)
Indirizzo psicologico sviluppatosi negli anni Cinquanta a Palo Alto in California. La psicologia sistemica ritiene di poter indagare il mondo psichico a partire dal sistema della comunicazione regolato dalle leggi della totalità, per cui il mutamento di una parte genera il mutamento del tutto; della retroazione, che prevede l’abbandono del concetto di causalità lineare per quello di circolarità dove ogni punto del sistema influenza ed è influenzato da ogni altro; e dell’equifinalità, per cui ogni sistema è la miglior spiegazione zione di se stesso, perché i parametri del sistema prevalgono sulle condizioni da cui il sistema stesso ha tratto origine.
Detta psicologia ha come suo presupposto teorico la teoria generale dei sistemi e come sua risultanza pratica la terapia sistemica.
1) Teoria generale dei sistemi
Studio dell’organizzazione di una totalità detta sistema. Secondo von Bertalanffy, esistono dei modelli, dei principi e delle leggi che si applicano a sistemi generalizzati o a loro sottoclassi, indipendentemente dal loro genere particolare, dalla natura degli elementi che lo compongono e dalle relazioni che si hanno tra essi.
Risulta pertanto lecito il richiedere una teoria non tanto dei sistemi di tipo più o meno speciale, ma dei principi universali che sono applicabili ai sistemi in generale. L’oggetto di studio di tale teoria consiste nella formulazione e nella derivazione di quei principi che sono validi per i “sistemi” in generale. Sono considerati precursori della teoria generale dei sistemi L.S. Vygotskij, J. Piaget e M. Wertheimer.
2) La terapia sistemica
Dalla teoria generale dei sistemi è stata ricavata una forma di terapia che parte dall’idea che tutte le volte che un sistema viene portato lontano dal suo stato di equilibrio, si determina una fase caratterizzata da un periodo di riorganizzazione del sistema ma incerta e aperta a molti possibili sviluppi.
In questa fase si inserisce l’operazione terapeutica, dove il terapeuta con le sue comunicazioni e teorie di riferimento, è considerato come un sistema che entra in contatto con un altro sistema che è il paziente, il gruppo, la famiglia o la comunità.
Psicologia sociale
- Editore: Pearson
- Autore: Michael A. Hogg , Graham M. Vaughan , Luciano Arcuri , Andrea Vincre
- Collana:
- Formato: Prodotto in piu? parti di diverso formato
- Anno: 2016
Settore della psicologia che possiede più di altri settori una sua autonomia; ha per oggetto gli aspetti sociali del comportamento umano, occupandosi di diversi ambiti di ricerca: fattori socioculturali sottostanti lo sviluppo della personalità, componenti sociali ciali delle singole funzioni psichiche, rapporto interpersonale, dinamiche dei gruppi, intesi si sia come piccoli gruppi sia come grandi aggregati umani, e psicologia dei mass-media.
È dell’inizio del secolo l’opera La psicologia dei popoli di W. Wundt, superata anche a causa della tesi dell’inapplicabilità del metodo sperimentale in psicologia sociale. Opere fondanti la nuova disciplina vengono considerate La psicologia sociale di E.A. Ross e Introduzione alla psicologia sociale di W. McDougall, entrambe del 1908, caratterizzate da un’interpretazione istintualistica del comportamento sociale.
Alcuni lavori, considerati storici in tale ambito, vennero utilizzati, in particolar modo in Francia e in Italia, per razionalizzare il significato delle frequenti rivolte popolari e del terrorismo di matrice anarchica – ad esempio la notissima Psicologia delle folle di G. Le Bon del 1915.
Dopo gli anni Venti, la psicologia sociale acquisisce un carattere di scientificità superando le dottrine istintualistiche anche grazie all’influenza del neonato comportamentismo e dell’antropologia culturale. Anche la sociologia influenza le dottrine di psicologia sociale, al punto, in particolar modo negli anni Trenta, da rendere necessaria una differenziazione dei diversi ambiti: da un lato, il contesto collettivo costituisce oggetto di studio di entrambe; dall’altro tro la sociologia si interessa del significato e delle determinazioni sociali dei comportamenti, mentre la psicologia li esamina in quanto espressi e vissuti dai singoli individui.
Sarà solo dopo gli anni Quaranta che la psicologia sociale si distinguerà definitivamente dalla sociologia diventando scienza sperimentale, in particolar modo sotto l’influenza della la Gestaltpsychologie della scuola del Massachusetts, capeggiata da K. Lewin, che si interessa ressa dello studio delle proprietà del “gruppo” inteso come “totalità”, non riducibile alle caratteristiche dei singoli membri.
La psicologia sociale contemporanea è, inoltre, fortemente influenzata da Freud, in particolare dall’opera Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1921). L’oggetto per eccellenza della psicologia sociale è il processo di socializzazione, caratteristica alla condizione umana.
Essa si suddivide in tre fasi:
- la relazione diadica, fondata sul bisogno fondamentale della gratificazione dei bisogni (relazione madre-bambino);
- la relazione triadica che si sviluppa col raggiungimento di una maggior autonomia e l’accettazione del confronto-competizione con una terza figura (paterna);
- la relazione di gruppo caratterizzata da vissuti di competitività (prima fra fratelli, poi nei confronti di individui esterni alla famiglia).
Nell’ottica psicodinamica, sono i vissuti di angoscia che spingono gli uomini alla socializzazione e questa richiede la presenza di un oggetto gratificante per essere superata; i sentimenti di colpa risultano dalla separazione dall’unità familiare originaria e dunque connessi al timore di una separazione definitiva da essa.
Ogni ambito teorico ha una sua interpretazione del processo di socializzazione: nella psicologia dell’età evolutiva è una tappa del processo evolutivo, mentre il cognitivismo sottolinea come la socializzazione sia promossa da un interesse reale per l’ambiente che il soggetto percepisce in base al proprio livello cognitivo, inoltre correlato alle sue precedenti denti esperienze.
Ogni individuo interagisce con la rappresentazione che ha degli altri, i quali, a loro volta, hanno una rappresentazione di lui. La psicologia sistemica considera l’individuo inserito in una rete ed è agendo su quel sistema, piuttosto che sul singolo individuo, che diviene possibile modificare le relazioni individuali.
Importante risulta, infine, il concetto di sociopatia, inteso sia come mancanza di socializzazione (asocialità) sia come gestione abnorme delle relazioni (antisocialità o, nei casi estremi, psicopatia).
La psicologia sociale si occupa dello studio e della valutazione dei processi di risocializzazione ne o degli interventi tesi a ridurre la dissonanza cognitiva che, in alcuni individui, non ha consentito il processo di socializzazione.
Psicologia umanistica
Orientamento psicologico ideato da A.H. Maslow (1954, 1964) che, ritenendo la psicologia dominante colpevole di aver basato la propria conoscenza dell’uomo sul dolore e sulla patologia, sui suoi aspetti deteriori, crea una “psicologia del benessere” nella quale si sottolinea che la “sanità” psicologica non solo fa star bene, ma è qualcosa di corretto e di vero.
Egli sottolinea il carattere di irriducibilità di ciascun individuo, le cui motivazioni all’azione possono essere immediatamente ricondotte a valenze non quantificabili, come l’autorealizzazione, la necessità di esplorazione, la natura della relazione con gli altri, la visione del mondo in cui si manifesta la propria identità e la creatività.
Maslow rivendica, quindi, l’autonomia dell’impianto motivazionale le rispetto alla dinamica pulsionale.
Psicobiologia
- Pinel, John P. J. (Autore)
Orientamento ideato da Adolf Meyer che, partendo dalla concezione dell’uomo come unità indivisibile, propone un trattamento capace di integrare lo psichico con il biologico, ritenendo la separazione un prodotto delle metodiche di studio.
Psicofarmacologia
- Schatzberg, Alan F. (Autore)
Branca della farmacologia che si occupa di chiarire, sperimentalmente e a fini terapeutici, l’azione delle sostanze chimiche sulle funzioni psichiche superiori. Nata agli inizi degli anni Cinquanta, la psicofarmacologia ha bisogno dell’apporto di molti ambiti disciplinari come la biochimica, la genetica, la psicofisiologia.
Oggi si è persuasi che gli psicofarmaci hanno un’azione più sintomatica che causale, nel senso che l’andamento del disturbo psichico risulta modificato più nelle sue manifestazioni esteriori che nelle sue dinamiche profonde.
La classificazione degli psicofarmaci è un problema un po’ controverso, fondamentalmente per due ragioni: perché le classificazioni strettamente farmacologiche non corrispondono alle distinzioni cliniche, e perché le classificazioni basate sull’attività clinico-terapeutica sono relative, dato che questi farmaci hanno una serie di azioni distinte che si ritrovano in gruppi diversi.
Sono stati adottati criteri di:
- classificazioni di tipo pragmatico che, in base all’effetto terapeutico dividono gli psicofarmaci in inibitori psichici, attivatori psichici e simulatori di psicosi;
- di tipo psicofisiologico che, in base all’effetto sulle attività del sistema nervoso, dividono gli psicofarmaci in neurolettici, antipsicotici, tipsicotici, ansiolitici, psicotogeni e antidepressivi;
- di tipo clinico che prevede una distinzione in psicolettici, psicoanalettici e psicodislettici.
Psicometria
- Editore: McGraw-Hill Education
- Autore: Carlo Chiorri
- Collana: College
- Formato: Prodotto in piu? parti di diverso formato
- Anno: 2014
Settore della psicologia che ha lo scopo di tradurre in termini numerici e quantitativi gli aspetti dell’attività psichica e gli aspetti normali e patologici della personalità, al fine di rendere oggettivi e descrittivi i fenomeni osservati.
Tale ambito si è sviluppato inizialmente, all’ interno della psicologia differenziale, rispetto alla quale si è venuta a configurare come l’insieme delle tecniche di rilevazione, elaborazione e interpretazione zione dei dati psicofisiologici, psicoattitudinali e, in seguito, caratteriologici.
Gli strumenti menti utilizzati in tal senso sono i test, misurazioni obiettive e standardizzate di un campione di comportamento.
I primi “test mentali”, utilizzati dagli psicologi alla fine dell’Ottocento, erano principalmente valutazioni condotte in laboratorio nell’ambito di esperimenti sulle reazioni psicofisiologiche e sulla valutazione di memoria, attenzione e altre aree ristrette del comportamento intelligente.
Tali studi, nati dall’esigenza di fornire alla neonata psicologia la dignità di “scienza esatta”, miravano alla costruzione di modelli teorici e leggi scientifiche.
Psicopatologia
- Editore: Pearson
- Autore: Jill Hooley , James N. Butcher , Matthew K. Nock , Susan Mineka , Giulia Buodo , Claudio Gentili , Marta Ghisi , Antonio Prunas , Carlo Pruneti
- Collana: Scienze
- Formato: Prodotto in piu? parti di diverso formato
- Anno: 2017
L’attuale psicopatologia descrittiva è debitrice della psicologia classica e della fenomenologia soggettiva di Jaspers. L’attività psichica è descritta dalla psicologia classica come suddivisibile in diverse facoltà, (noetica, affettiva e volitiva), ciascuna comprensiva di diverse funzioni di cui vengono separatamente descritte le alterazioni.
La psicopatologia classica prende origine alla fine del secolo scorso, con lo scopo di descrivere gli accadimenti psicopatologici (alterazioni psichiche e comportamentali) come riferiti dai malati o come osservati dai clinici, indipendentemente dagli specifici disturbi in cui si ritrovano.
L’approccio clinico descrittivo di Kraepelin e Bleuler si avvalse di tale psicopatologia, fondata sui comportamenti osservabili piuttosto che sui vissuti soggettivi.
Nel 1913, Jaspers scrive la sua psicopatologia generale che segna una svolta nella storia della psichiatria, ponendo come base per l’indagine psicopatologica il continuo processo di immedesimazione (Einfuhlung), che il clinico attua nei confronti dei vissuti del paziente, riportando continuamente a se stesso le esperienze psichiche riferite dal paziente stesso.
La psicopatologia di Jaspers, definita comprensiva, rivaluta il mondo interno del soggetto che viene indagato dal continuo rapportarsi dell’esaminatore all’esaminato; non riveste importanza che i vissuti siano spiegabili o meno dalle scienze naturali.
L’incomprensibilità psicologica di un vissuto segna il limite dell’esperienza psicotica: tutto ciò in cui non sia possibile immedesimarsi viene definito psicotico.
L’attuale indagine psicopatologica tiene conto di tali matrici, osservando, quindi, i comportamenti visibili, i vissuti del paziente e del clinico. A livello interpretativo, la psicopatologia è debitrice dei maggiori orientamenti: dinamico, cognitivo-comportamentale e neurobiologico.
Psicofisica
Disciplina che cerca di stabilire le leggi che regolano i rapporti esistenti tra uno stimolo, inteso come fenomeno fisico di intensità definita e misurabile, e la risposta costituita da una sensazione di determinata intensità a esso corrispondente.
La psicofisica emancipò la psicologia dall’ambito filosofico, in cui fino ad allora questa scienza si era espressa in termini fondamentalmente qualitativi.
Ultima revisione
RIF. Tratto dal libro: “Psicologia dinamica. Dalla psicoanalisi freudiana alle neuroscienze”Il timone
- Contattami via e-mail Scrivi qui >>
- LEGGI SOS Autostima >>