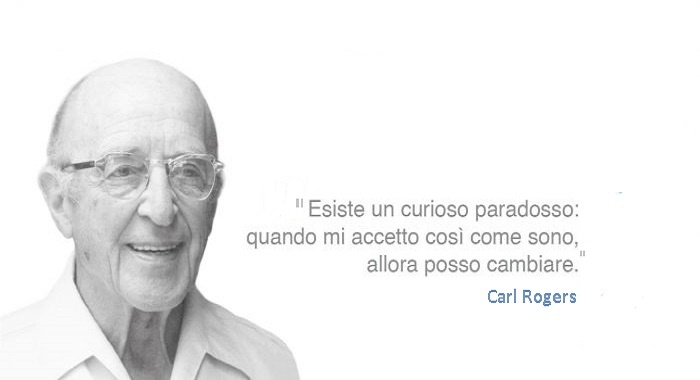Carl Rogers venne definito “un rivoluzionario silenzioso“. Quella definizione descriveva appropriatamente la vita e l’opera di un uomo capace di generare profondi cambiamenti nel campo della psicoterapia e, in generale, in quelli delle relazioni umane.
Consapevole dei pericoli insiti nell’etichettamento delle diagnosi psicopatologiche, Rogers fu il primo a formulare una visione della natura umana basata sulla fiducia nella capacità innata di ogni individuo a tendere alla salute e all’autoregolazione.
In aperta contraddizione con l’orientamento diffuso in tutti gli altri approcci a focalizzarsi sulla psicopatologia, Rogers fu anche primo nell’impiegare la ricerca in psicoterapia e a verificare le sue ipotesi attraverso lo studio delle verbalizzazioni (protocolli) dei trattamenti.
Egli fu infatti il primo (nel 1942) ad audio-registrare e pubblicare interi colloqui di complete psicoterapie, fornendo così una messe di dati scientifici verificabili e allo stesso tempo rendendosi disponibile ad una valutazione pubblica e alle possibili critiche dei colleghi.
Mostrò così, coraggiosamente, come realizzava momento per momento con i suoi utenti il setting terapeutico, e questo in un’epoca in cui le informazioni erano limitate agli appunti delle sedute stilati dai terapeuti stessi. In tal modo egli ha offerto un modello del ruolo integrato del clinico-ricercatore.
Rogers fu anche il primo a incoraggiare negli psicoterapeuti l’acquisizione di una nuova consapevolezza, e cioè che disegnare e gestire un setting clinico costituisce una vera e propria propria costruzione sociale della realtà, da cui inevitabilmente discendono, in modo consapevole o inconsapevole, le politiche relazionali in psicoterapia.
Si trattava di fare una scelta di campo, che egli esplicitò attraverso il rifiuto del termine “paziente” che riteneva contenesse concettualmente il ruolo passivizzante a cui il “cliente” in molti orientamenti psicoterapici era apertamente relegato.
La terapia centrata sul cliente di Carl Rogers
Comprendere l’altro non attraverso una serie precostituita di categorie diagnostiche; comprendere l’altro aprendosi ad esso autenticamente, con profondo rispetto; comprendere empaticamente come l’altro costruisce il proprio rapporto con se stesso, gli altri, il mondo.
Questo principio costituisce la pietra miliare dell’epistemologia della Psicoterapia Centrata sul Cliente e della sua pratica psicoterapeutica.
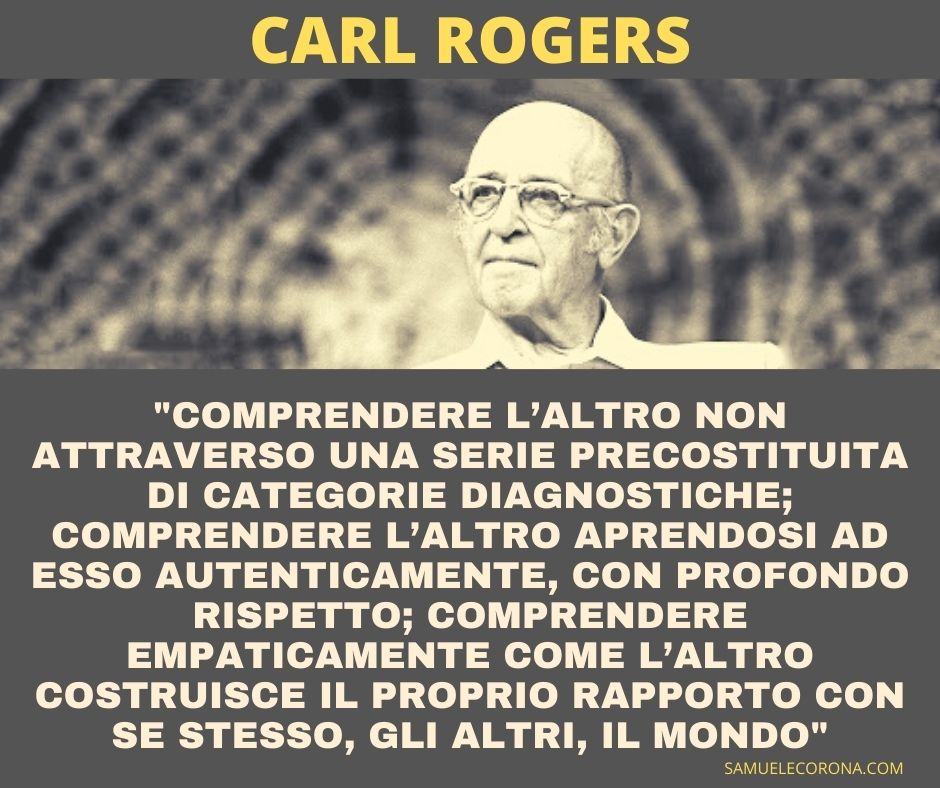
Le 19 proposizioni
La teoria della personalità di Rogers si sviluppa intorno a tre concetti fondamentali ai quali, nel tempo, si sono aggiunte e integrate altre riflessioni: l’organismo (o individuo totale), il campo fenomenico e il Sé.
La natura di questi concetti e la loro reciproca relazione sono state esposte in 19 proposizioni.
#1. “Ogni individuo esiste in un mondo continuamente mutevole di esperienze, del quale esso è il centro”.
Il termine “esperienza” si riferisce a qualsiasi cosa accada all’individuo in un dato momento dal punto di vista fisiologico, sensorio o motorio, un insieme di eventi che l’individuo può conoscere “in modo completo e genuino” cosciente-mente.
L’individuo è il miglior esperto di se stesso. Se il terapeuta vuole entrare in contatto con il mondo del suo cliente è importante che si ponga nei suoi confronti con una attitudine di ascolto rispettoso
#2. “L’organismo reagisce al campo appena lo riconosce. Questo campo percettivo è per l’individuo la realtà”.
L’individuo in quanto organismo reagisce agli stimoli esterni o alle perturbazioni interne non in quanto tali ma in relazione alle sue esperienze soggettive in modo differente.
Due persone che ricevono lo stesso stimolo possono percepire due realtà diverse. Per comprendere una persona non basta conoscere gli stimoli a cui essa viene sottoposta, ma anche come da essa vengano vissuti.
#3. “L’organismo reagisce come un tutto organizzato al suo campo fenomenico”.
Da un punto di vista olistico, Rogers nega la validità di una psicologia segmentale della persona in favore di una rivolta all’individuo come “sistema totalizzante e organizzato” capace di “risposte globali”. L’essere umano va considerato tutto intero nel suo insieme e non può essere scisso in parti separate.
#4. “L’organismo ha una tendenza fondamentale, quella di attualizzare, mantenere ed esaltare l’organismo esperimentante”.
Tutti i bisogni organici e psicologici sono aspetti parziali di questo bisogno, di questa tendenza direzionale fondamentale che porta l’individuo, anche affrontando disagi e dolori, a muoversi verso una sempre maggiore autonomia, maturità e socializzazione.
Quando un individuo percepisce una possibilità di scelta e questa viene adeguatamente simbolizzata, tale scelta sarà sempre quella di progredire e mai regredire.
#5. “Il comportamento è fondamentalmente il tentativo, diretto a un preciso scopo, dell’organismo di soddisfare le sue esigenze così come egli le esperimenta, nel campo così come egli lo percepisce”.
Benché vi siano molteplici “esigenze” ciascuna è subordinata alla tendenza di base dell’organismo, la “forza motivante”, a mantenere ed esaltare se stesso.
Il comportamento viene attivato non dalla realtà oggettiva ma dalla percezione che l’individuo ha della realtà, i bisogni sono diversi ma sono al tempo stesso unificati nella motivazione unica dell’attualizzazione.
#6. “L’emozione accompagna e in genere facilita tale comportamento diretto allo scopo, poiché l’emozione è in relazione più con la ricerca che con gli aspetti del comportamento relativi al soddisfacimento dei bisogni, e l’intensità dell’emozione è in relazione con il significato percepito del comportamento per il mantenimento e l’esaltazione dell’organismo”.
In particolare, secondo Rogers, le emozioni forti dovute all’eccitamento, come la rabbia, aiutano l’individuo nel comportamento di ricerca mentre quelle più calme, come la soddisfazione, aiutano a portare a compimento lo scopo. Nessuna emozione è di per sé dannosa sino a quando noi restiamo ben radicati e coscienti nei nostri veri bisogni.
#7. “Il miglior punto di partenza per la comprensione del comportamento sta nel sistema di riferimento dell’individuo stesso”.
Secondo Rogers, le auto-descrizioni sono la fonte privilegiata degli psicologi nell’accesso al vissuto interiore degli individui più delle conclusioni tratte da test, esperimenti comportamentali e osservazioni. Quando il terapeuta è sinceramente interessato a comprendere il cliente e capace di stabilire con lui un clima di calore e fiducia, allora il cliente è facilitato ad aprirsi alla comunicazione sempre più profonda e rivelatrice del suo mondo soggettivo.
#8. “Una parte del campo percettivo totale si differenzia gradualmente, divenendo il Sé”.
Dopo aver descritto il comportamento dell’organismo in un’ottica fenomenologica, Rogers introduce il concetto di Sé come campo differenziato all’interno del campo fenomenico totale, ossia come insieme di esperienze che hanno come orizzonte di riferimento l’Io o Me stesso.
#9. “In conseguenza dell’interazione con l’ambiente, e particolarmente come risultato di interazioni valutative con altri, si forma la struttura del Sé: come configurazione concettuale organizzata, fluida, ma coerente, di percezioni, di caratteristiche e relazioni dell’Io o Me, insieme con i valori attribuiti a questi concetti”.
Nel corso dell’ontogenesi, l’individuo impara che vi sono nozioni che gli permettono di distinguere se stesso e ciò che gli appartiene connotativamente e altre proprie dell’ambiente esterno. Queste esperienze di sé assumono, quindi, dei valori positivi e negativi.
I problemi insorgono quando la valutazione del bambino non include solo le sue dirette esperienze con l’ambiente, ma le valutazioni espresse da altri essere umani.
- Rogers, Carl R. (Autore)
#10. “I valori attribuiti alle esperienze e i valori che sono una parte della struttura del Sé sono, in alcuni casi, valori sviluppati direttamente dall’organismo, e in altri casi valori sviluppati o assunti da altri, ma percepiti in maniera alterata come se fossero stati sviluppati direttamente”.
Questa proposizione riguarda la complementarietà tra valori acquisti attraverso delle esperienze proprie e valori eterodiretti e poi introiettati. L’aspetto cruciale della dinamica interna al mondo valutativo dell’individuo riguarda il carattere consensuale o conflittuale del compromesso così come è percepito dal soggetto nella socializzazione e individuazione.
Maggiore è l’incongruenza tra il proprio processo organismico di valutazione ed i valori esterni introiettati e maggiore sarà la difficoltà nel soddisfare i propri veri bisogni e quindi ad essere pienamente se stessi. Questo è secondo Rogers il meccanismo dell’estraniazione e della psicopatologia.
#11. “Le esperienze che vengono registrate nella vita dell’individuo possono essere: a) simbolizzate, percepite e organizzate in relazione al Sé; b) ignorate, perché non si percepisce alcuna relazione con la struttura del Sé; c) simbolizzate in maniera alterata o addirittura negate, in quanto l’esperienza non è in armonia con la struttura del Sé”.
La percezione dell’individuo è frutto di una selezione regolata da criteri di coerenza. Le reazioni alle esperienze degli stimoli sono orientate dalla struttura del Sé che determina la forma della loro assunzione, rimozione o negazione.
#12. “La maggior parte dei comportamenti adottati dall’organismo sono quelli coerenti con il concetto di Sé”.
Questo aspetto della personalità diventa problematico se esiste una notevole incongruenza tra i propri reali bisogni percepiti a livello organistico e l’immagine che uno ha di se stesso: in questo caso la soddisfazione dei bisogni diviene problematica: una persona con dei valori morali molto rigidi, che considera la sessualità come qualcosa di sporco, avrà grosse difficoltà a soddisfare le proprie naturali esigenze di intimità sessuale.
#13. “Il comportamento può, in alcuni casi, essere determinato da esperienze e necessità organiche che non sono state simbolizzate. Tale comportamento può non essere coerente con la struttura del Sé, ma in questi casi il comportamento non è “proprio” dell’individuo”.
A volte i bisogni organismici dell’individuo vengono così ripetutamente disattesi che l’organismo crea un canale per la soddisfazione di tale bisogno senza che il bisogno stesso emerga coscientemente nell’individuo.
In questi casi è tipica la reazione: “non posso credere di aver potuto fare una cosa simile!” oppure: “ero fuori di me!”. Non riconoscendo la paternità del proprio atto l’individuo salva l’immagine che s i è formata di se stesso.
#14. “Il cattivo adattamento psicologico esiste quando l’organismo nega alla consapevolezza significative esperienze viscerali e sensorie, che conseguentemente non sono simbolizzate e organizzate nella Gestalt della struttura del Sé. Quando si verifica questa situazione, vi è tensione fondamentale o potenziale”.
Il non prestare ascolto ai propri bisogni basilari perché questi minacciano l’immagine del Sé porta l’individuo ad estraniarsi dalla su a vera natura, e questa incongruenza può affiorare come tensione non meglio identificata.
- Editore: Carocci
- Autore: Daniele Bruzzone
- Collana: I tascabili
- Formato: Libro in brossura
- Anno: 2007
#15. “L’adattamento esiste quando il concetto del Sé è tale che le esperienze sensorie e viscerali dell’organismo sono o possono esser assimilate a livello simbolico in una relazione coerente con il concetto del Sé”.
Quando esiste congruenza tra valutazione organismica e il concetto di Sé la persona è, secondo la definizione di Rogers, pienamente funzionante e la sua innata tendenza attualizzante non trova ostacoli sul proprio cammino.
#16. “Ogni esperienza che non è coerente con l’organizzazione o la struttura del Sé può venir percepita come una minaccia, e, più numerose sono queste percezioni, più rigidamente si organizza la struttura del Sé per sostenersi”.
In questa proposizione Rogers espone la conseguenza basilare della dicotomia tra l’organismo e il Sé dell’individuo. Di fronte a delle esperienze che possono costituire una minaccia, il Sé costituisce delle difese che però allontanano l’individuo dal contatto con l’organismo.
#17. “In certe condizioni, che comportino principalmente un’assenza assoluta di minaccia alla struttura del Sé, possono venir percepite ed esaminate esperienze non coerenti con essa, e la struttura del Sé può venir modificata in modo da assimilarle e includerle”.
In un clima psicologicamente sicuro, in cui l’individuo non si percepisce in una situazione di pericolo, si apre il campo d’intervento della psicoterapia in cui il terapeuta lavora alla ricomposizione della dicotomia tra il Sé e l’organismo del paziente.
#18. “Quando un individuo percepisce e accetta in un sistema coerente e integrato tutte le sue esperienze sensorie e viscerali, è necessariamente portato maggiormente a comprendere gli altri e ad accettarli come individui”.
Il risultato dell’accettazione e dell’assimilazione delle esperienze dapprima negate o rimosse è rappresentato dal fatto che l’individuo diviene più comprensivo non solo con se stesso ma anche con il prossimo.
#19. “Mentre l’individuo percepisce e accetta nella struttura del suo Sé una maggior quantità di esperienze del suo organismo, si accorge che sta sostituendo il suo attuale sistema di valori, basato largamente su introiezioni simbolizzate in modo distorto, con un continuo processo di rivalutazione”.
L’accettazione porta l’individuo ad abbandonare i suoi rigidi sistemi di valori per entrare con fiducia in un processo continuo d’assimilazione e adeguamento delle esperienze il cui funzionamento determina l’adeguatezza o meno dell’adattamento.
Bibliografia:
- “Terapia centrata sul cliente” di Carl R. Rogers
- “La teoria della personalità di Carl R. Rogers” di Luca Corchia (www.researchgate.net)
- “La visione della natura umana e del cambiamento secondo Carl Rogers” di Alberto Zucconi (www.explorans.it)
Carl Rogers. Libri più venduti online
Ecco i 3 libri di Carl Rogers più venduti online, con informazioni sul prezzo e valutazione di chi li ha acquistati.
- Contattami via e-mail Scrivi qui >>
- LEGGI SOS Autostima >>