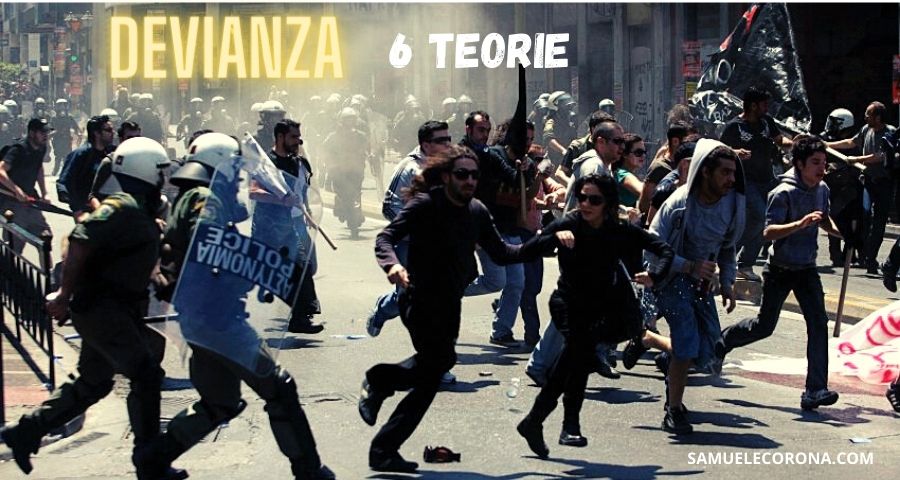Il termine devianza è comprensivo non solo dei fenomeni criminali, ma anche di altri comportamenti, come il suicidio, l’alcolismo o la malattia mentale.
Per devianza, si intende ogni atto o comportamento di una persona o di un gruppo che viola le norme di una collettività e che va incontro a una qualche forma di sanzione, disapprovazione, condanna o discriminazione.
Un atto viene definito deviante non per la natura stessa del comportamento, ma per la risposta che suscita nell’ambiente socioculturale in cui ha luogo.
Molto spesso la sociologia della devianza si è occupata dei fenomeni criminali, generando in molti l’idea erronea di un’identificazione tra criminalità e devianza. In realtà, se è vero che la criminalità fa parte della devianza, i due fenomeni non coincidono.
La criminalità, si riferisce a quelle attività che infrangono non una qualsiasi norma, ma la legge e che sono soggette alle punizioni applicate dai magistrati in quanto rappresentanti dello stato.
5 Categorie di devianza
Secondo Simon Dinitz, sociologo statunitense che sviluppò la sua teoria della devianza negli anni ’60 e ’70 del XX secolo; esistono 5 categorie di devianza e, conseguentemente, 5 tipologie di devianti:
#1. La devianza come contrasto rispetto al prevalente modello fisico, fisiologico o intellettivo. Questo è il caso degli individui deformi e dei minorati psichici.
#2. La devianza come infrazione delle norme religiose e ideologiche e che rifiuta l’ortodossia. Questo è il caso degli eretici e dei dissidenti.
#3. La devianza come infrazione delle norme giuridiche. Il caso dei ladri e degli assassini.
#4. La devianza come comportamento difforme dalla definizione culturale di salute mentale. Il caso degli individui psicopatici e dei nevrotici.
#5. La devianza come rifiuto dei valori culturali dominanti. Questo è il caso degli hippy o dei punk.
6 Teorie sulla devianza
La ricerca di una causa al fenomeno della devianza è antica: i primi tentativi di indagine sono stati di tipo biologico; da questi la ricerca sociologica si è nel tempo allontanata, concentrando la propria attenzione su fattori di ordine sociale e culturale.
#1. La teoria biologica della devianza
Nonostante i tentativi compiuti da Lombroso, di rintracciare i segni della devianza in determinati caratteri somatici (per lo più del cranio), e di ritenere la tendenza criminale come carattere geneticamente appreso, le teorie biologiche della devianza sono ritenute prive di fondamento scientifico.
La tesi biologica della criminalità è stata ripetutamente sostenuta in varie forme, anche più recentemente, nel 1977 da Eysenck e nel 1987 dai lavori di Mednick.
– Devianza e struttura fisica secondo Sheldon
Numerose ricerche si sono concentrate sull’analisi dell’albero genealogico di famosi criminali al fine di rintracciare elementi che consentissero di individuare l’ereditarietà del fenomeno. Questi studi non sono riesciti a dimostrare l’incidenza che i fattori ambientali hanno avuto nella formazione della personalità dei criminali.
Intorno agli anni ’40, William A. Sheldon riprese l’idea dell’influenza biologica sulla devianza presentando tre tipi principali di struttura fisica umana: mesomorfi, ectomorfi ed endomorfi.
Secondo Sheldon i mesomorfi, muscolosi e attivi, avevano maggiori probabilità di diventare criminali rispetto ai soggetti più magri (ectomorfi) o più grassi (endomorfi).
Nonostante il successo suscitato da questa impostazione, rimane valida l’obiezione secondo cui la presenza di persone muscolose e attive tra i criminali non è sufficiente per dimostrare una correlazione tra caratteri fisici e tendenza criminale.
– Teoria cromosomica
Secondo studi condotti verso la fine degli anni ’70, alcuni ricercatori hanno ritenuto di poter collegare le tendenze criminali alla presenza di un particolare gruppo di cromosomi.
Sembrava che tra i prigionieri nelle carceri di massima sicurezza si registrasse un’alta percentuale di individui con un cromosoma Y in più rispetto a quanto non si verifichi normalmente (1 su 100, rispetto a 1 su 1000 della popolazione complessiva).
Questi dati non sono però stati confermati da ulteriori ricerche effettuate nella stessa direzione. Nonostante sia possibile che alcuni caratteri biologici possano creare una sorta di predisposizione a compiere determinati reati, allo stato attuale non si registrano prove conclusive sul rapporto diretto tra ereditarietà e azione criminale.
#2. La devianza come prodotto di situazioni anomiche
Sulla base della rielaborazione del concetto durkheimiano di “Anomia”, il sociologo americano Robert Merton ha sviluppato una teoria che considera la devianza come un prodotto delle situazioni anomiche.
Quando, sostiene Merton, all’interno della società sorge un conflitto tra fini socialmente approvati e mezzi socialmente approvati disponibili, nel soggetto si genera uno stato di conflitto che ne favorirà la devianza.
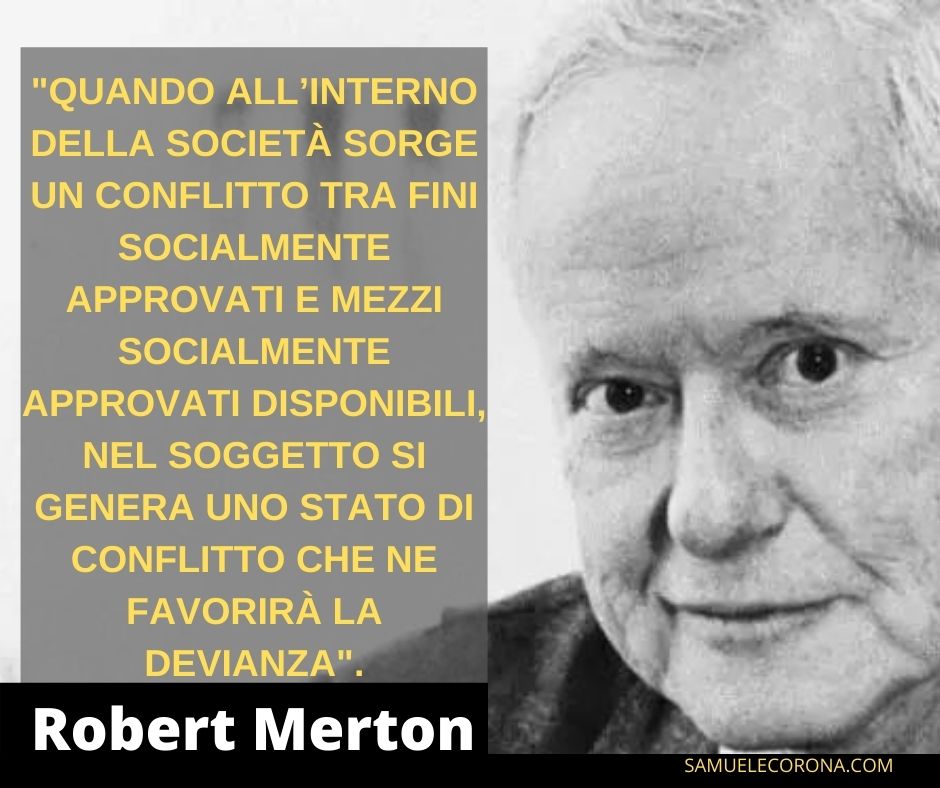
In altre parole, viviamo società che proclamano la ricchezza e il successo economico come mete supreme, ma che al contempo offrono i mezzi legali per raggiungere tali mete solo a un’esigua minoranza.
La spinta al successo e al benessere economico viene sentita dunque come necessità sociale, ma per gli individui esclusi dai mezzi socialmente approvati una tale meta risulta irraggiungibile.
Il furto e la truffa si presentano allora come espedienti per ottenere quanto è reso costantemente desiderabile da parte della società.
Analizzando il processo di socializzazione degli americani, Robert Merton rileva come questo si fondi sul valore del successo e sulla denigrazione (mediante la definizione di “fallito”) di quanti non lo raggiungono.
A livello individuale, tuttavia, il perseguimento del successo non viene accompagnato dalla capacità di accettare come unici strumenti possibili quelli ammessi dalla società, per cui quando tali strumenti risultano inaccessibili nel soggetto si viene a creare una situazione di profondo disagio (anomia).
Leggi: “Teoria e struttura sociale” l’opera fondamentale di Robert Merton
#3. La teoria psicologica della devianza
Diversi autori hanno cercato di spiegare i fenomeni criminali in termini di “psicopatia”, “degenerazione” e in generale legati a problemi di ordine psichico.
Spesso questi studiosi hanno cercato di rintracciare la causa della devianza in situazioni familiari patogene relative all’infanzia del soggetto. Il comportamento delinquenziale, secondo diverse teorie psicologiche, non sarebbe altro che l’espressione sintomatica delle tensioni provocate da situazioni familiari pregresse e mai superate dal soggetto.
- De Martis, Lucia (Autore)
Nonostante la pluralità dei modelli interpretativi, la maggioranza delle indagini condotte in questo campo tende a ricondurre le radici della devianza a conflitti non risolti, a processi di identificazione psicologica, a meccanismi reattivi accaduti in particolari situazioni dell’infanzia e dell’adolescenza del soggetto.
In questo senso si sono sviluppate numerose ricerche tendenti a verificare secondo quali modalità alcuni fattori come: la carenza di cure materne, la disgregazione familiare, l’assenza della figura paterna, la disciplina familiare; possano contribuire alla formazione di una personalità antisociale.
Leggi anche: La Triade Oscura | Il narcisista, il machiavellico, lo psicopatico
#4. La teoria dei fattori culturali
Secondo diversi autori, per comprendere i fenomeni devianti è necessario esaminare i fattori culturali e di valori ai quali il deviante fa riferimento.
I primi studi intrapresi in questa direzione furono quelli di Clifford Shaw e Henry McKay, che nel 1929 effettuarono un’imponente ricerca sul tasso di delinquenza nella città di Chicago. Dopo aver suddiviso la città in cinque zone concentriche, Shaw e McKay calcolarono il rapporto tra il numero di coloro che avevano commesso reati e la popolazione totale della zona considerata.
Dalla ricerca emergeva che il tasso di delinquenza così ottenuto diminuiva quanto più ci si allontanava dal centro cittadino. Qui risiedevano in prevalenza immigrati di diverse provenienze, mentre nelle aree semiperiferiche risiedevano gli operai specializzati e, in quelle ancora più esterne, i ceti medi.
I ricercatori scoprirono inoltre che i tassi di delinquenza erano assai simili a quelli registrati a partire dal 1900, nonostante gli abitanti delle diverse zone e la stessa composizione etnica si fossero modificati nel corso degli anni.
Secondo i due sociologi la spiegazione andava ricercata nei diversi contesti valoriali presenti nelle aree. In alcuni quartieri erano presenti regole e valori favorevoli a certe forme di devianza, che venivano di volta in volta trasmessi ai nuovi membri del gruppo.
– Teoria dell’associazione differenziale
Riprendendo questo tipo di analisi, Edwin Sutherland ha elaborato la “teoria dell’associazione differenziale“. In base a tale teoria si assume che “un individuo diventa delinquente a causa del prevalere di definizioni favorevoli alla violazione della legge rispetto a definizioni sfavorevoli a tale violazione”.
Ciò significa che all’interno dei diversi gruppi della medesima società possono essere presenti sistemi culturali differenti, i quali incoraggiano comportamenti considerati devianti dalla società nel suo complesso. Va da sé che gli individui che crescono all’interno di questi sistemi risulteranno molto più predisposti alla devianza di chi appartiene a contesti sociali diversi.
- Editore: Il Mulino
- Autore: Frank P. III Williams , Marilyn D. McShane , V. Scalia
- Collana: Manuali. Scienze sociali
- Formato: Libro
- Anno: 2002
Le origini della devianza andrebbero pertanto ricercate nei processi di socializzazione che normalmente si verificano all’interno di piccoli gruppi e dei quali l’individuo finisce per accogliere norme e valori.
Un fattore determinante nella formazione della personalità individuale sarebbe non tanto il contatto con le istituzioni astrattamente intese, quanto piuttosto il rapporto effettivo istituito dal soggetto con individui particolari, bande e gruppi.
Un’implicazione di questa teoria è stata evidenziata dai sociologi Cohen e Nisbet, per i quali la devianza tenderebbe a diffondersi in quelle società (tipo le metropoli occidentali) in cui sono presenti diverse subculture.
In questo caso, infatti, diversamente da quanto accade nelle piccole comunità, la disomogeneità culturale provocherebbe delle difficoltà nella trasmissione dei comportamenti approvati dalla società.
#5. Labeling theory (Etichettamento)
Secondo il sociologo Howard Becker, tra i massimi esperti di Labeling Theory (teoria dell’etichettamento), il nucleo dei processi devianti è da rintracciare nelle norme che definiscono un determinato comportamento come lecito o deviato.
Nessun comportamento è deviante, sostiene Becker, ma lo diviene nel momento in cui esso viene definito tale.
Il problema diviene allora quello di capire quali gruppi sociali definiscono qualcosa come lecito o deviante e per quali fini. L’analisi della devianza manifesta allora i rapporti di potere vigenti in una determinata società.
È infatti chi detiene il potere reale a imporre la propria definizione di norma, etichettando chi non vi si attiene come outsider.
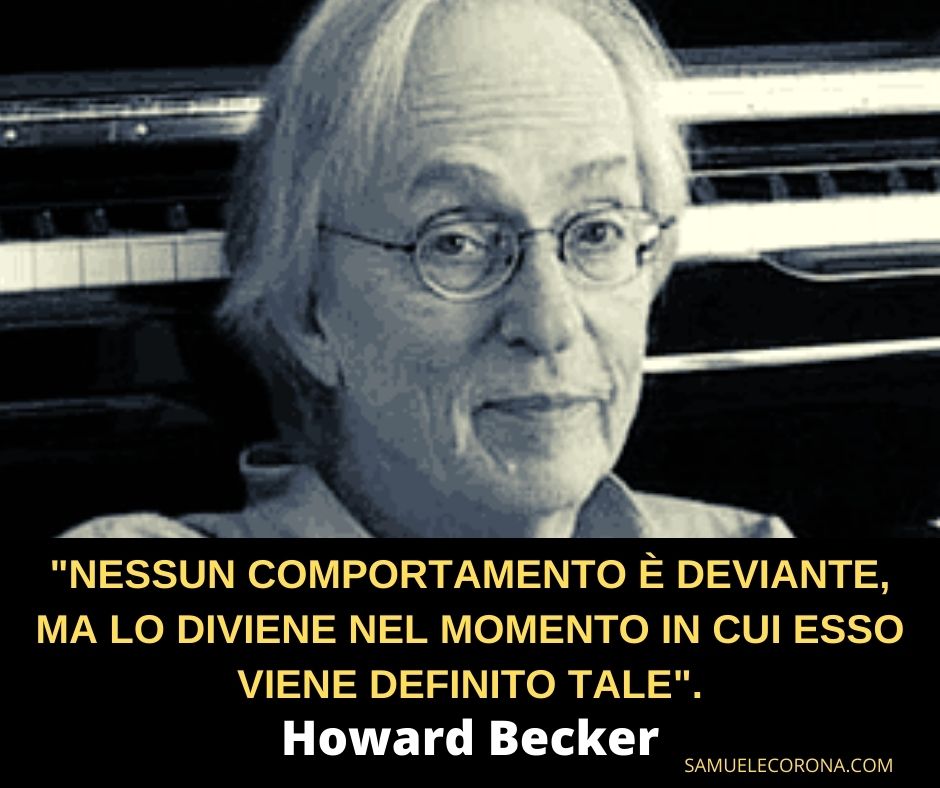
Accade così che le regole di definizione della devianza e i contesti a cui esse si applicano vengono stabiliti per lo più dai ricchi per i poveri, dagli uomini per le donne, dagli anziani per i giovani e dalle maggioranze etniche per i gruppi minoritari.
Molti bambini, per esempio, fanno cose come entrare nel giardino degli altri, rompere finestre, rubare frutta o marinare la scuola. Ma questi comportamenti vengono considerati diversamente a seconda del contesto in cui si verificano.
Così il medesimo fatto può essere considerato una “monelleria” in un quartiere borghese, un sintomo di devianza in una zona proletaria.
– Devianza primaria e secondaria
Questa diversa considerazione non rimane però priva di conseguenze: un individuo, una volta etichettato come delinquente, verrà considerato e trattato come tale, aumentando in tal modo la distanza con il resto della società. In proposito Edwin Lemert parla di devianza primaria.
A questo primo momento della trasgressione segue, infatti, una volta che il soggetto stesso ha accolto l’etichetta di deviante e si percepisce dunque come tale, la devianza secondaria, un atteggiamento, cioè, che radicalizza la propensione trasgressiva del soggetto in questione.
Da queste teorie trae spunto una critica alle istituzioni preposte a controllare il comportamento deviante: in altri termini, riformatori e prigione avrebbero come effetto il passaggio dell’individuo alla devianza secondaria.
Da qui l’affermazione di Edwin Lemert secondo cui non è la devianza a richiedere il controllo sociale, ma è il controllo sociale a generare la devianza.
Ho parlato di etichettamento nel post: 7 Tecniche di manipolazione da conoscere assolutamente
#6. La funzionalità sociale della devianza
Albert K. Cohen ha esaminato le modalità tramite le quali i comportamenti devianti facilitano il funzionamento della vita sociale.
Mediante la punizione dei comportamenti definiti devianti, la società riafferma le proprie regole precisandone aspetti che altrimenti resterebbero vaghi e al contempo fornisce un rinforzo a chi agisce in modo conforme.
Spesso la devianza ha costituito la spia del disagio sociale e della presenza di un’organizzazione sociale difettosa: per esempio, le rivolte nelle carceri possono essere sintomatiche dell’arretratezza del sistema carcerario.
In ogni caso, la definizione di un comportamento, o di un individuo, come deviante ha la conseguenza di sollecitare la coesione del gruppo. Il deviante viene infatti concepito come nemico sul quale la collettività concentra i sentimenti di frustrazione e insoddisfazione.
Egli diviene in questo modo il capro espiatorio di tensioni indipendenti da se stesso.
Secondo Dennis Chapman. il criminale è il capro espiatorio di una società che ha bisogno di trasferire su qualcosa di esterno l’aggressività generata dai suoi stessi sistemi.
Articoli consigliati:
- Influenza Sociale Invisibile | I Fattori che influenzano il comportamento
- Gli 8 Elementi della Riforma del Pensiero | Robert Lifton
- Obbedienza all’autorità di Stanley Milgram | 8 Concetti chiave | Libro Riassunto
Bibliografia:
Devianza. 3 Libri più venduti online
Ecco i 3 libri sulla Devianza più venduti online, con informazioni sul prezzo e valutazione di chi li ha acquistati.
- Contattami via e-mail Scrivi qui >>
- LEGGI SOS Autostima >>